Schiavi della teologia
di PierLuigi Zoccatelli (il Domenicale. Settimanale di cultura, anno 2, numero 47, sabato 22 novembre 2003, p. 10)
[presentazione del volume di Anonimo bizantino, I segreti dell’iconografia bizantina. La “Guida alla pittura”, da un antico manoscritto, a cura di PierLuigi Zoccatelli, Arkeios, Roma 2003, 272 pp., euro 19,90]
All’origine dell’edizione francese – lungamente introdotta e altrettanto lungamente annotata, diversamente da come abbiamo scelto di fare per l’edizione italiana, che preferiamo «parli» al lettore di oggi attraverso le semplici pagine dell’«antico manoscritto bizantino», piuttosto che mediante il filtro di un commentatore posteriore – troviamo Adolphe Napoléon Didron (1806-1867). Archeologo influenzato dal Romanticismo, amico di Victor Hugo (1802-1885) e appassionato del Medioevo, Didron fu segretario del Comité historique des Arts et Monuments, animò il Bulletin archéologique e in seguito gli Annales archéologiques – riviste nelle quali trovavano posto anche temi d’iconografia, musica e architettura – e aprì una fabbrica di vetri dipinti e una fonderia di bronzo. Nel clima di un’epoca e all’interno di una cultura, di cui nel prosieguo cercheremo di fornire alcune direttrici, Adolphe Napoléon Didron – nelle parole dello storico Jean-Pierre Laurant, al quale dobbiamo il reperimento di una copia di quest’antico volume (ciò per cui sentiamo il dovere di ringraziarlo sentitamente) – «rimase colpito dall’unità della composizione e dal carattere metafisico delle regole che i monaci si trasmettevano, sia oralmente sia sotto forma di note manoscritte, ogni generazione aggiungendo il proprio contributo. Avendo ottenuto uno di tali quaderni, lo pubblicò come una delle fonti più antiche dell’arte sacra tradizionale in Occidente». Il quadro è così delineato, ma vale la pena fare un passo indietro. Dunque, fra l’agosto e il settembre 1839 Adolphe Napoléon Didron si reca in viaggio in Grecia per studiare da vicino gli affreschi e i mosaici d’arte bizantina che così tanto lo interessavano, trascrivendo nei propri quaderni numerosi appunti e rimanendo fortemente colpito dalle costanti iconografiche che attraversano periodi storici così distanti fra loro: «Né il tempo né il luogo smuovono in nulla l’arte greca; nel XVIII secolo il pittore continua e ricalca il pittore veneziano del X secolo e il pittore atonita del V o VI secolo. Il costume dei personaggi è ovunque e sempre il medesimo, non solo nella forma, ma nel colore, nel disegno, finanche nelle pieghe. Non si potrebbe spingere più in là l’esattezza tradizionale. In Grecia, l’artista è schiavo del teologo; la sua opera, che sarà ricopiata dai suoi successori, copia quella dei pittori che l’hanno preceduto. L’artista greco è asservito alle tradizioni come l’animale al suo istinto. L’arte gli appartiene, ma solo l’arte; perché l’invenzione e l’idea appartengono ai padri, ai teologi, alla Chiesa». Finalmente giunto al Monte Athos, Didron ebbe modo di soddisfare le sue più intime curiosità, accedendo agli atelier di vari monasteri e chiese ove venivano preparati gli affreschi e le icone, rimanendo ulteriormente sbalordito per la rapidità e precisione con la quale i maestri pittori eseguivano i dipinti o davano istruzioni ai loro allievi, senza l’ausilio di tracciati, schemi grafici o note. Finché, dopo un mese di peregrinazioni nel Monte Athos, Adolphe Napoléon Didron tornò al monastero di Esphigménou, dove il monaco-pittore Joasaph gli espresse con semplice candore quei «segreti dell’arte pittorica» che stavano a tal punto scombussolando l’animo del francese. «Ma, signore – mi disse infine –, tutto ciò è meno straordinario di quanto voi dite, e mi colpisce il vostro stupore. Tenete, ecco un manoscritto dove ci viene insegnato tutto quello che dobbiamo fare. Qui si insegna a preparare il mortaio, i colori, a comporre e disporre le tavole; là sono riportate le iscrizioni e le sentenze che dobbiamo dipingere e che mi avete udito dettare ai miei giovani allievi. Guardai subito, impressionato e con avidità, il manoscritto che mi veniva mostrato da Joasaph, e appresi che si componeva di quattro parti. Il manoscritto aveva per titolo: Guida della pittura». Adolphe Napoléon Didron giudicava di avere fra le mani un manoscritto antico di poco meno di trecento anni (XV-XVI secolo), ma dalla redazione ancor più primitiva (i monaci lo attribuivano al X-XI secolo, per quanto sia difficile l’attribuzione paleografica), e – nel tentativo vano di acquistarlo – apprese che ogni atelier del Monte Athos disponeva di una copia manoscritta. Iniziava così un’ulteriore peregrinazione alla ricerca di una copia in vendita del manoscritto, finché Didron dovette rassegnarsi all’idea che per quella strada non avrebbe ottenuto quanto desiderato. Fino a che riuscì a convincere il monaco Macarios – pittore rinomato al Monte Athos quanto Joasaph – a farsene trascrivere una copia da un giovane monaco, partendo dal manoscritto in suo possesso: «Macarios possedeva un bell’esemplare del manoscritto greco: era il più antico e quello che mi sembrava eseguito più accuratamente. Il pittore rifiutava di cedermi il suo esemplare. Questa bibbia della sua arte era situata nel mezzo dell’atelier e due dei suoi più giovani allievi lo leggevano alternatamente ad alta voce, mentre gli altri erano intenti a dipingere ascoltando la lettura. Si offrì di farmene eseguire una copia nell’arco di due mesi, da parte di un monaco noto come il miglior scriba della montagna, per il costo di duecentottanta piastre (settanta franchi). Accettai con riconoscenza». Ecco com’è giunto fino a noi, poi tradotto in francese dal greco per conto di Durand, in vista della pubblicazione del 1845, da parte del suo amico Paul Durand, questo antico manoscritto bizantino. Nel corso del quale il lettore cercherà invano tutti i dettagli dell’arte pittorica bizantina – esso presuppone infatti in vari punti conoscenze acquisite tramite uno studio approfondito; e talune ricette comprendono ingredienti assai difficili da identificare, al punto che la consultazione può risultare incompleta o difficile –, per quanto avrà l’opportunità di confrontarsi con quella che abbiamo definito in esordio «una grammatica dell’iconografia cristiana». Come ricordava Durand nel proporre la traduzione francese del manoscritto, «l’opera si compone di quattro parti. Nella prima, tutta tecnica, si espongono i procedimenti pittorici impiegati dai Greci, la maniera di preparare i colori, di disporre gli affreschi e le tavole. Nella seconda parte sono descritti, in dettaglio e con una precisione degna di nota, i soggetti simbolici, ma soprattutto la storia che il dipinto può rappresentare. La terza parte determina il luogo ove conviene porre tale soggetto o personaggio di preferenza a quell’altro, in una chiesa, un portico, un refettorio o una fontana. Infine, un’appendice fissa il carattere di Cristo e della Vergine e fornisce alcune iscrizioni che abbondano nelle pitture bizantine». Vi è che questo manoscritto, interamente fruibile di per sé e a prescindere dalle considerazioni che ora sentiamo di dovere aggiungere, vide la luce – come abbiamo detto – «nel clima di un’epoca e all’interno di una cultura». Si tratta, in effetti, del periodo e della cultura che permisero al monaco benedettino (poi cardinale) Jean-Baptiste Pitra (1812-1889) di scrivere, il 24 giugno 1853, rivolgendosi a dom Prosper Guéranger (1805-1875), il celebre abate dell’abbazia Saint-Pierre di Solesmes: «Mi sembra che al compimento di questo lavoro, sarò in diritto di concludere che il simbolismo è una scienza; giacché ci sono delle regole e delle formule; una scienza tradizionale, poiché troviamo serie di monumenti e di insegnamenti; una scienza matura che non ammette né lo scetticismo degli uni né l’arbitrarietà degli altri, e che non riserva soprattutto alcuno spazio per le immaginazioni private, le fantasticherie a priori, una cabala fantastica, ecc.». Dom Pitra si riferiva qui al grande lavoro di riscoperta del simbolismo cristiano, al quale si dedicava soprattutto in relazione alla sua scoperta del testo nella versione del Codex Claromontanus della Chiave attribuita al Padre della Chiesa san Melitone, vescovo di Sardi nel II secolo, e pubblicata in Italia nel 1999 (Jean-Pierre Laurant, Simbolismo e Scrittura. Il cardinale Pitra e la «Chiave» di Melitone di Sardi, a cura di PierLuigi Zoccatelli, Arkeios, Roma). Un lavoro di riscoperta, quello di Pitra, per il quale la pubblicazione del manoscritto bizantino da parte di Didron costituiva un riferimento essenziale, nell’ottica della creazione di una «grande scuola di simbolismo cristiano», nell’ambito di un contesto culturale formato da quella parte dell’élite cattolica che riscopriva il linguaggio simbolico come parte essenziale della Tradizione cristiana, come opportunamente ricostruito nel brano seguente: «Dal canto suo, il simbolismo, veicolo privilegiato delle verità spirituali, fu l’oggetto di una posta in gioco capitale nel XIX secolo. Il Romanticismo tedesco, con Friedrich Schleïermacher (1768-1843) e Joseph von Görres (1776-1848), aveva combinato il ritorno al cristianesimo con l’universalismo; tempo di resurrezione, secondo l’espressione di Friedrich Novalis (1772-1801). Friedrich Schlegel (1768-1834) aveva già annunciato la rivelazione di tutti i misteri e si ritrova quella “intelligenza analogica, sintetica e intuitiva” in La symbolique di Friedrich Creuzer (1771-1858), che con Görres, Louis de Bonald (1754-1840), Joseph de Maistre (1753-1821) e Félicité de Lamennais (1782-1854) furono le letture più diffuse nei seminari della Restaurazione, da cui uscirono i dotti canonici delle cattedrali e i curati delle parrocchie rurali avidi di leggende. Joseph Guigniaut (1798-1876) tradusse La symbolique in francese, nel 1825. Le tesi di Creuzer, professore all’università di Heidelberg, dopo avere conosciuto un enorme successo, declinarono assieme alla “scienza romantica” in seguito agli attacchi, in particolare, dell’Antisymbolique di Johann-Heinrich Voss (1751-1826), nel 1824, e poi di Christian Lobeck (1781-1860). La Francia seguì con qualche anno di ritardo e numerosi furono quelli che, principalmente nella Chiesa, si convinsero dell’unità primordiale del simbolismo, uno dei punti forti del pensiero di Creuzer. Il padre gesuita Charles Cahier (1807-1882) aveva pubblicato con questo spirito, nel 1847, un in-folio sulle vetrate della cattedrale di Bourges, ma in seguito rinunciò a questa tesi con grande scandalo del colto Pitra, esperto ellenista, che aveva tentato di applicare il metodo storico per dimostrare che i testi latini medievali riuniti con il nome di Chiave e attribuiti al vescovo Melitone di Sardi, del II secolo, provenivano da un originale greco e costituivano il codice primitivo del simbolismo dei Padri. L’archeologo romantico Adolphe Didron, amico di Victor Hugo, era andato a cercare sul Monte Athos la guida segreta della pittura, fonte di un’arte sacra universale. Ebbe la stesa sorte della Chiave. Malgrado le battaglie nelle retrovie, gli Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, che contengono il testo definitivo della Chiave, apparvero solo nel 1884; Emile Soldi (1846-1906), dal canto suo, in missione ufficiale per conto del Ministero dell’Istruzione pubblica in Oriente, credette di trovare la lingua universale dei simboli e pubblicò nel 1892 La langue sacrée; così, l’esperto Fernand de Mely (1852-1935), che nel medesimo periodo interpretava le gemme con identico criterio; la tesi fu abbandonata in nome della storia. L’influenza delle opere composte su tali basi restò nondimeno molto viva, come si constata dagli scritti di Félicie d’Ayzac (1801-1881) sulle torri di Saint Denis, di don Louis Corblet (1819-1886), fondatore della rivista L’Art chrétien e autore di un Vocabulaire des symboles, o di don Charles Auber (1804-1892), storico del simbolismo» (Jean-Pierre Laurant, L’Ésotérisme chrétien en France au XIXe siècle, L’Age d’Homme, Losanna 1992, pp. 39-40). E l’itinerario sin qui descritto non si conclude con il XIX secolo, ma prosegue fino a XX secolo inoltrato, come dimostra il caso eclatante dell’iconografo francese Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946), del quale presso la casa editrice Arkeios di Roma abbiamo curato le migliaia di pagine dedicate al simbolismo cristiano. Una grammatica dell’iconografia cristiana, dicevamo, di cui dunque anche la pubblicazione in traduzione italiana dell’antico manoscritto bizantino costituisce una traccia, che non mancherà di riprendere il filo di un discorso – in verità mai interrotto – con i «nuovi grammatici». |
![]()
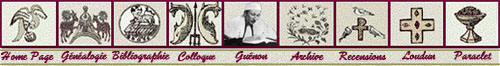
© 1997-2003 by PierLuigi Zoccatelli